|
Links sponsorizzati
| |
SPECIALE ACQUA |
ACQUA
> SPECIALE ACQUA > LA POLITICA DELL'ACQUA
> PER LA TUTELA DELLE ACQUE
La politica dell'acqua
Per la tutela delle acque
Questo decreto legislativo è stato definitivamente approvato dal Consiglio
dei Ministri. 23 anni e un giorno dopo la firma della legge 319/76 (cosiddetta
legge Merli), l'11 maggio 1999 il Capo dello Stato ha firmato il decreto legislativo
n. 152, pubblicato poi sul supplemento ordinario della Gu del 29 maggio 1999.
Le finalità del decreto
Le finalità della 152/99
sono riportate nell'articolo 1 e sono:
- prevenire e ridurre l'inquinamento
e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinanti;
- conseguire il miglioramento
dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari
usi;
- concorrere a perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale
di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di sostenere
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Gli
strumenti
Le finalità della 152/99 sono perseguite con i seguenti
strumenti:
- l'individuazione di obiettivi di qualità per tutti
i corpi idrici;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo
Stato, nonché la definizione di valori limite di emissione (in concentrazione
e in massa/tempo) da parte delle Regioni, in relazione agli obiettivi di qualità
del corpo idrico recettore;
- l'individuazione di misure tese alla conservazione,
al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche;
- l'adeguamento
dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;
- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di
ciascun bacino idrografico e un adeguato sistema di controlli e di sanzioni.
 |
| L'Aquila:
la fontana delle 99 cannelle |  | Le
principali innovazioni
Gli elementi principali che caratterizzano
il nuovo testo sono individuabili nei seguenti punti:
- il pieno recepimento
della direttive comunitarie 271 e 676 del 1991;
- l'introduzione del criterio
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici come riferimento basilare per
la definizione degli interventi di tutela;
- l'uso di indicatori capaci di
valutare lo stato ambientale non solo su criteri di tipo chimico, ma anche di
tipo biologico e tossicologico;
- la tutela integrata degli aspetti quantitativi
e qualitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico, rafforzando le indicazioni
per il corretto e razionale uso delle acque.
L'impostazione che caratterizzava
la legge 319/76, basata sostanzialmente solo sulla definizione di limiti allo
scarico, è stata cambiata spostando l'attenzione dal controllo del singolo
scarico all'insieme degli eventi che determinano l'inquinamento del corpo idrico.
Il dlgs 152/99 è caratterizzato da un approccio combinato (obiettivi
di qualità ambientale del corpo idrico recettore + limiti di emissione).
Infatti, pur mantenendo i limiti allo scarico, demanda la loro modifica e integrazione
alle Regioni sulla base delle esigenze di risanamento di ogni corpo idrico. Alle
misure relative alla qualità degli scarichi dovranno concorrere misure
atte alla difesa quantitativa della risorsa.
Gli obiettivi di qualità
È stato previsto
un doppio (parallelo e contestuale) sistema di obiettivi di qualità:
- un obiettivo, riguardante particolari funzioni o destinazioni d'uso, a
cui sono destinati specifici corpi idrici;
- l'obiettivo di qualità
ambientale relativo a tutti i corpi idrici significativi.
Gli obiettivi
riguardanti specifiche destinazioni d'uso
Fanno riferimento a norme
vigenti e interessano i corsi d'acqua che le Regioni e gli enti locali individuano
per un particolare uso o per una specifica funzione.
Rientrano tra questi
usi e funzioni:
- la produzione di acqua potabile;
- la balneazione;
- la qualità delle acque designate come idonee alla vita dei ciprinidi
e dei salmonidi;
- la qualità delle acque idonee alla vita dei molluschi.
Gli obiettivi di qualità ambientale
L'obiettivo di qualità
ambientale esprime un concetto più ampio di quello legato alle destinazioni
d'uso. Riguarda infatti non solo la qualità idrochimica ma l'intero ecosistema
acquatico (acque, sedimenti, sponde e biota) sia sotto l'aspetto quantitativo
che qualitativo.
In particolare, per le acque superficiali, esprime lo stato
dei corpi idrici in funzione della loro capacità di mantenere e di supportare
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, il più possibile
vicine alla condizione naturale in cui non appaiono significative modificazioni
dell'ecosistema prodotte dall'attività umana e in cui il sistema mantiene
intatte le sue capacità di risposta e autodifesa dalle perturbazione prodotte
da tali attività grazie ai processi naturali di autodepurazione.
I corpi idrici significativi, sulla base dei dati del monitoraggio e in base ai
criteri di classificazione contenuti nell'Allegato 1 alla legge, devono essere
classificati dalle Regioni nei diversi stati di qualità ambientale, che,
a seconda dei corpi idrici considerati, sono:
| Acque
superficiali |  |
| | Acque
marine
costiere |
Acque
di
transizione | |
Elevato |
Elevato |
Buono | |
Buono |
Buono |
Sufficiente |
| Sufficiente
| Mediocre
| Scadente
| | Scadente
| Scadente
| |
| Pessimo
| |
| | Acque
sotterranee |  |
| Elevato |
| Buono
| | Sufficiente
| | Scadente
| | Stato
naturale particolare
| | |
Lo stato
di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali viene definito
in base:
- allo stato ecologico, che è espressione della qualità
della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici;
- allo stato
chimico, che è stabilito in base alla presenza dei principali inquinanti
pericolosi, inorganici e di sintesi.
Lo stato di qualità ambientale
dei corpi idrici sotterranei è definito sulla base dello:
-
stato quantitativo, che indica la sostenibilità, sul lungo periodo,
dello sfruttamento della risorsa; è indicativo del rapporto tra i prelievi
in atto e le capacità naturali di ravvenamento;
- stato chimico,
che riguarda la condizione idrochimica dell'acquifero e la presenza di inquinanti
pericolosi.
Con i Piani di tutela (considerati come piano stralcio del piano
di bacino previsto dall'articolo 17 della legge 183/89) devono essere adottate,
a livello di bacino, le misure per raggiungere lo stato ambientale buono entro
il 31 dicembre 2016 in ogni corpo idrico significativo. È inoltre prevista,
per i soli corpi idrici superficiali, una tappa intermedia da raggiungere entro
il 31 dicembre 2008.
Aree che richiedono
specifiche misure di prevenzione
La nuova legge individua anche
zone per le quali, in ragione della loro fragilità, sono previste particolari
attenzioni, specifiche misure di prevenzione e norme vincolistiche.
 |
| Un gioco
d'acqua |  | Aree
sensibili
Sono riferite a quei corpi idrici esposti al rischio di eutrofizzazione
e dove sono previsti trattamenti di depurazioni più spinti per gli scarichi
in esse recapitanti. In prima istanza sono individuate dalla legge le seguenti
aree, che potranno essere integrate e modificate dalle Regioni sulla base di criteri
definiti nell'allegato 6:
- i laghi (al di sotto dei 1.000 metri slm) e i
corsi d'acqua a essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla loro immissione
nel lago;
- le aree lagunari e i laghi salmastri;
- le zone umide individuate
ai sensi della convenzione di Ramsar;
- le aree costiere dell'Adriatico nord-occidentale
dalla foce dell'Adige a Pesaro e i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto
di 10 chilometri all'interno della linea di costa.
Zone vulnerabili
da nitrati di origine agricola
Una prima elencazione di tali aree è
contenuta nell'Allegato 7, insieme ai criteri per la designazione, ove necessario,
di ulteriori zone vulnerabili da parte delle Regioni e delle Province autonome,
sentita l'Autorità di bacino. Nelle zone così individuate, devono
essere rispettate le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola
(pubblicato sulla Gu n. 86 del 4 maggio 1999).
Zone vulnerabili da
prodotti fitosanitari
Con le stesse modalità previste per le zone
vulnerabili da nitrati, sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7,
le Regioni e le Province autonome identificano le zone vulnerabili, allo scopo
di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento
proveniente dall'uso di prodotti fitosanitari.
Aree di salvaguardia
delle risorse idriche destinate al consumo umano
Sono individuate da
Regioni e Province autonome per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative
delle acque destinate al consumo umano (dpr 236/88) e per la tutela dello stato
delle risorse. Sono distinte in:
- aree di ricarica delle falda;
- emergenze
naturali e artificiali della falda;
- zone di riserva.
Norme per favorire il risparmio e l'utilizzo appropriato
della risorsa
Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad
assicurare l'equilibrio tra la disponibilità della risorsa e i fabbisogni
per i diversi usi, tenendo conto del minimo deflusso vitale, della capacità
di ravvenamento della falda e della destinazione d'uso della risorsa compatibile
con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
Le autorità
competenti effettuano la revisione delle concessioni delle grandi e piccole derivazioni,
secondo le priorità indicate dall'Autorità di bacino, al fine del
mantenimento o del perseguimento degli obiettivi di qualità e della necessità
di garantire il minimo deflusso vitale. Le concessioni di utilizzazione delle
acque minerali sono subordinate al pieno soddisfacimento delle esigenze potabili.
L'articolo 23 della legge, poi, riporta alcune modifiche al regio
decreto 1775/33 atte a garantire un più razionale uso della risorsa attraverso:
-
l'obbligo
a utilizzare risorse più appropriate per i diversi usi (non va usata l'acqua
potabile per lavare le strade o irrigare i giardini o per altri usi che non richiedono
particolari qualità):
- l'utilizzo di
risorse riservate all'uso potabile comporta il triplicamento del canone di concessione;
- è previsto un decreto attuativo per definire norme tecniche per il riutilizzo
agricolo delle acque reflue.
-
criteri
per le concessioni. Nel concedere derivazioni e autorizzare nuovi pozzi, nella
scelta tra più domande concorrenti è preferita la domanda che da
sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenti la più
razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
- l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti
anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni
spreco e destinando le risorse qualificate all'uso potabile;
- le effettive
possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
- la quantità
e la qualità dell'acqua restituita;
- in caso di più domande
concorrenti per usi industriali è preferita quella del richiedente che
aderisce al sistema di ecogestione e audit ambientale di cui al regolamento comunitario
1836/93 Cee.
-
sono
previste sanzioni maggiori per prelievi non autorizzati (si sottolinea in particolare
l'abrogazione di alcune parti dell'articolo 17 del regio decreto 1775/33 che rappresentano
una sorta di sanatoria);
-
per
incentivare il riutilizzo di acque già usate è previsto, per le
utenze industriali, un coefficiente aggiuntivo alla tariffa d'ambito (o al canone
di depurazione), riferito al rapporto tra acqua primaria e acqua già utilizzate
nel processo produttivo;
-
vengono
date indicazioni alle Regioni e alle Province autonome affinché vengano
adottate norme per:
- migliorare la manutenzione delle reti di adduzione
e di distribuzione al fine di ridurre le perdite;
- prevedere la realizzazione
di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi
compatibili;
- disporre per le nuove costruzioni, e incentivare per gli edifici
già esistenti, l'utilizzo di tecnologie di risparmio della risorsa;
- installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità
abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive
e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- prevedere sistemi
di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue;
- prevedere negli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico
e territoriale, reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonché
tecnologie di risparmio della risorsa. Il Sindaco rilascia la concessione edilizia
se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unità
abitativa, nonché contatori differenziati ove già disponibili reti
duali. Le
Regioni e le Province autonome devono inoltre adottare programmi per il contenimento
dei consumi, per il riciclo dell'acqua e per il riutilizzo delle acque reflue
depurate mediante i quali:
- sono prescritti gli usi delle migliori tecniche
disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto
delle norme tecniche emanate ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994,
numero 36;
- sono indicate le modalità del coordinamento interregionale
anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di
depurazione di acque reflue;
- sono previsti incentivi e agevolazioni alle
imprese che adottano impianti di riutilizzo;
- sono predisposte opportune
convenzioni con gli enti gestori del servizio idrico integrato e con altri enti
per la ricerca, l'informazione e la diffusione dei metodi per il risparmio idrico
domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.
Le norme di
emissione
Le norme sugli scarichi sono caratterizzate da un approccio
combinato tra limiti di emissione e obiettivi di qualità. Viene ridefinito
un sistema di limiti di emissione costituito:
- da limiti fissati centralmente
(legge 319/76 e direttiva 76/464 Cee riguardanti le sostanze pericolose e direttiva
91/271Cee per le acque reflue urbane);
- limiti fissati dalle Regioni e dalle
Province autonome, nell'ambito dei piani di tutela, sulla base degli obiettivi
di qualità.
I limiti fissati localmente potranno essere diversificati
per ogni corpo idrico superficiale in relazione al carico ammissibile per raggiungere
l'obiettivo di qualità. Questi limiti dovranno essere anche in termine
di carico, cioè di massa nell'unità di tempo (ad esempio kg/mese),
oltre che in concentrazione.
I
limiti per le acque reflue urbane
Dall'entrata in vigore della legge 152/99
tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane dovranno rispettare
i limiti indicati nella tabella in basso.
Gli impianti provenienti da agglomerati
con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in mare, e quelli provenienti
da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti recapitanti in acque dolci
superficiali o acque di transizione, devono dotarsi di trattamento appropriato,
che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi
di qualità, o la tutela delle acque sotterranee nel caso di scarico nel
suolo.
Tali trattamenti devono essere individuati con l'obiettivo di: a)
rendere semplice la manutenzione e la gestione; b) essere in grado di sopportare
adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico; c) minimizzare
i costi gestionali. Questa tipologia di trattamento può equivalere a un
trattamento primario o a un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica
adottata e dei risultati depurativi raggiunti.
Per tutti gli insediamenti
con popolazione compresa tra 50 e 2000 abitanti equivalenti, si ritiene auspicabile
il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione,
o tecnologie come i filtri percolatori o impianti a ossidazione totale.
Peraltro,
tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati,
al fine del raggiungimento dei limiti fissati, anche a tutti gli insediamenti
in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30 per cento della
popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo
consentano. Tali trattamenti si prestano, per gli insediamenti di maggiori dimensioni
con popolazione compresa tra i 2.000 e i 25.000 abitanti equivalenti, anche a
soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del
trattamento, con funzione di affinamento.
L'Allegato 5 fornisce inoltre alcune
indicazioni per altri inquinanti: rende obbligatorio prevedere i trattamenti di
disinfezione e richiede di non superare negli scarichi una percentuale (30 per
cento) di azoto ammoniacale rispetto all'azoto totale.
|
Limiti di emissione per gli impianti
di acque reflue urbane |
| Potenzialità
impianto in abitanti equivalenti | | |
2.000 - 10.000 |
>10.000 | |
Parametri | Concentrazione |
% di riduzione |
Concentrazione |
% di riduzione | |
1 BOD5 mg/l
|
<_25 |
70-90 | <_25 |
80 | | 2
COD mg/l | <_125 |
75 | <_125 |
75 | | 3
Solidi Sospesi mg/L | <_35 |
70 | <_35 |
90 | | | | | | |
| I
tempi di adeguamento
In ottemperanza alla direttiva 91/271 Cee, gli scarichi
esistenti alla data di entrata in vigore della legge rimangono soggetti alle normative
emanate dalle Regioni e dalle Province autonome e dovranno conformarsi ai limiti
previsti per i nuovi scarichi: entro il 31.12.2000, se provenienti da agglomerati
con oltre 15.000 abitanti equivalenti; entro il 31.12.2005 se con popolazione
compresa tra 2.000 e 15.000 abitanti equivalenti. Negli stessi tempi gli insediamenti
in questione dovranno dotarsi di fognatura. I
limiti per le acque reflue industriali
Per gli scarichi in corpi idrici
superficiali delle acque reflue industriali rimangono invariati i limiti esistenti
in base alla legge 319/76 e 133/92.
Per gli scarichi di acque reflue industriali
recapitanti in fognatura valgono i limiti indicati nell'Allegato 5, oppure i limiti
fissati dal gestore della pubblica fognatura, se già definiti e se l'impianto
di trattamento al servizio della fognatura è perfettamente funzionante
e in grado di rispettare i limiti dello stesso allegato.
Tali scarichi, saranno
soggetti alle norme dettate dalle Regioni al fine del raggiungimento dell'obiettivo
di qualità stabilito per il corpo idrico recettore.
I limiti per le
sostanze pericolose dovranno rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato
5 e per alcune di queste non potranno essere meno cautelativi di quelli indicati
nello stesso allegato. Gli
scarichi sul suolo e nel sottosuolo
Salvo le eccezioni previste, non possono
essere attivati nuovi scarichi nel sottosuolo e sul suolo. Gli scarichi che recapitano
nel sottosuolo dovranno cessare entro il 31 dicembre 2000 e quelli sul suolo dovranno
cessare entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo testo di legge.
Gli
scarichi di acque reflue urbane o di acque reflue industriali, che in virtù
delle eccezioni contemplate nel nuovo testo di legge e specificate nell'Allegato
5 continuano a recapitare sul suolo, dovranno conformarsi alle indicazioni e ai
limiti contenuti nell'Allegato 5.
Tali eccezioni riguardano in particolare
l'esistenza di rilevanti problemi di ordine tecnico relativi alla idrografia,
alla geologia e alla morfologia del territorio, o il caso di elevate distanze
dal più vicino corpo idrico superficiale.
Tutela
delle aree di pertinenza dei corpi idrici
Al fine di assicurare il
mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente
adiacente ai corpi idrici, con funzioni di tutela dall'inquinamento diffuso da
contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, la legge demanda
alle Regioni e alle Province autonome il compito di disciplinare gli interventi
di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia
di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune. È comunque
vietata la copertura dei corsi d'acqua, a meno che non sia imposta da ragioni
di tutela della pubblica incolumità e per la realizzazione di impianti
di smaltimento dei rifiuti.
Le aree del demanio fluviale di nuova formazione,
ai sensi della legge 5 gennaio 1994, numero 36, non possono essere oggetto di
sdemanializzazione.
|
Norme abrogate dalla legge 11
maggio 1999 n.152 |
 Con
la nuova legge 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento
vengono abrogate le seguenti norme: Con
la nuova legge 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento
vengono abrogate le seguenti norme: -
legge
10 maggio 1976, n. 319; -
legge
8 ottobre 1976, n. 690, di conversione con modificazioni del decreto legge 10
agosto 1976, n. 544; -
legge
24 dicembre 1979, n. 650; -
legge
5 marzo 1982, n. 62, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre
1981, n. 801; -
decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515; -
legge
25 luglio 1984, n. 381 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 maggio
1984, n. 176; -
gli articoli
4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione in legge del decreto legge
5 febbraio 1990, n. 16; -
decreto
legislativo 25 gennaio, 1992, n. 130;
-
decreto
legislativo 27 gennaio, 1992, n. 131; -
decreto
legislativo 27 gennaio, 1992, n. 132; -
decreto
legislativo 27 gennaio, 1992, n. 133; -
articolo
2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione con modificazione
del decreto legge 9 ottobre 1993, n. 408; -
articolo
9 bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione con modificazioni del
decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552; -
legge
17 maggio 1995, n. 172, di conversione del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79.
| |
Il
piano di tutela
Una considerazione specifica va fatta su un tema
che è stato una delle principali fonti di contrasto nel confronto con le
Regioni: lo schema procedimentale scelto per l'approvazione del piano di tutela.
Tale procedura prevede tre momenti:
a) la definizione di
obiettivi e criteri generali da parte dell'Autorità di bacino (entro il
31.12.2001);
b) la redazione dei piani di tutela da parte delle
Regioni (entro il 31.12.2003);
c) la formulazione del parere vincolante
da parte delle Autorità di bacino e l'approvazione finale del piano da
parte delle Regioni entro il 31.12.2004.
Il parere dell'Autorità
di bacino non deve entrare nel merito delle scelte puntuali fatte dalle singole
Regioni, ma deve verificare la coerenza generale dei diversi piani e la conformità
degli stessi ai criteri e agli obiettivi definiti all'inizio dall'Autorità
di bacino.
Questa divisione di competenze, che tiene conto dell'attuale
impostazione normativa derivata dalla legge 183/89 sulla difesa del suolo, è
tesa a salvaguardare le specificità dei due enti (più pianificatorio
il primo, programmatorio e soprattutto gestionale e operativo il secondo), assegnando
il compito di redazione del piano e la definizione degli interventi alle Regioni.
Il piano di tutela, costituendo un piano stralcio di settore del piano di bacino
della legge 18 maggio 1989 n. 183, si pone nella gerarchia della pianificazione
del territorio come un piano sovraordinario "perché i vincoli posti
dal predetto piano obbligano immediatamente le amministrazioni e gli enti pubblici
(statali e regionali) i quali sono tenuti a osservarli e a operare in conseguenza"
(Corte Costituzionale, sentenza numero 13 del 2 febbraio 1995). Questo dovrebbe
facilitare il coordinamento con gli altri piani regionali ambientali e la conformità
ai piani urbanistici.
Il sistema messo a punto è in realtà
uno strumento di garanzia proprio per le Regioni, in particolar modo per quelle
che si trovano a valle. Evita infatti che lo sforzo fatto per perseguire gli obiettivi
sia vanificato da scelte non coerenti operate a monte. Cosa può fare il
Veneto per risanare l'Adige se a questo obiettivo non contribuiscono le province
di Trento e Bolzano? Riuscirà l'Emilia Romagna a migliorare la qualità
del Po e dell'Adriatico prima che Milano depuri le sue acque e che il Lambro diventi
più pulito?
Sanzioni e danno ambientale
Oltre a una
serie di sanzioni amministrative, e in alcuni casi penali, è previsto un
sistema di risarcimento del danno ambientale provocato da comportamenti in violazione
della legge.
In particolare, chi provoca un danno alle acque, al suolo e ad
altre risorse è tenuto al rispristino ambientale. Il ministero dell'Ambiente
ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con gli interventi
di bonifica. A tal fine, quando non sia possibile una precisa quantificazione
economica, è previsto un sistema automatico basato sull'entità della
sanzione amministrativa o sulla sanzione penale erogata. In
conclusione, bisogna ricordare che i nodi critici da affrontare per l'applicazione
della legge sono principalmente:
- quello finanziario e gestionale;
- quello dei controlli.
Un primo aspetto è quello finanziario
relativo all'entità delle risorse da reperire e alle forme di finanziamento.
La stima più recente individua infatti in circa 60.000 miliardi la somma
di investimenti necessari ad adeguare il sistema fognario e depurativo italiano.
È peraltro giusto sottolineare che tale somma è in media con quelle
previste dagli altri paesi dell'Unione europea. Infatti la media italiana per
abitante equivalente è di lire 540.000 contro il massimo della Germania
di circa 1.200.000 e il minimo di 220.000 della Grecia.
Tali risorse
finanziarie possono essere coperte solo in parte dallo Stato, mentre la grossa
parte deve essere coperta attraverso la messa in atto del sistema tariffario previsto
dalla legge 36/94, che purtroppo ancora stenta a partire.
Il secondo aspetto,
quello gestionale, riguarda in parte anche esso il tema finanziario (non basta
trovare i soldi per costruire l'impianto, bisogna anche farlo funzionare), ma
anche il miglioramento delle capacità tecniche progettuali e gestionali.
Infatti non sempre gli interventi effettuati raggiungono un livello sufficiente
nel rapporto costi/benefici. Molte volte gli impianti sono troppo piccoli per
essere gestiti bene, altre volte sono inutilmente complessi per le esigenze locali
e, infine, troppo spesso i comuni e gli enti gestori non hanno personale abbastanza
preparato per gestirli. Su questi temi il ministero dell'Ambiente si sta attrezzando
per dare indicazioni operative o linee guida.
Il secondo nodo riguarda
la grave carenza di strutture capaci di garantire un monitoraggio efficace e continuativo
della qualità dei corsi d'acqua e degli scarichi. Non si tratta solo di
carenze strutturali, ma anche di carenze culturali: non si comprende ancora appieno,
infatti, l'importanza che hanno il monitoraggio, la raccolta, l'analisi e l'aggiornamento
delle informazioni per la gestione delle acque e il risanamento dei corpi idrici.
C'è la necessità di colmare al più presto questa grave
lacuna, anche attraverso la raggiunta piena funzionalità del sistema Anpa/Arpa.
Un altro elemento da sottolineare riguarda una carenza che ancora la nuova normativa
non ha completamente superato. Non si è infatti riusciti ad assumere compiutamente
un'impostazione della tutela, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa
al controllo degli scarichi, basata su criteri ecotossicologici.
Uno
sforzo in tal senso è stato fatto e ciò si può cogliere soprattutto
da una lettura attenta dell'Allegato relativo ai criteri di monitoraggio e classificazione
dei corpi idrici, ma l'impostazione culturale, tecnica e politica che ancora contraddistingue
alcuni importanti ministeri non ha permesso ulteriori passi avanti in tal senso.
Bisogna comunque sottolineare come l'impostazione del citato allegato, oltre a
introdurre ampiamente tali concetti, è sufficientemente elastico da permettere
una successiva evoluzione in tal senso di tutta la legge. Per questi motivi, anche
se la realtà del mondo tecnico e scientifico richiedeva avanzamenti più
spinti, i piccoli passi avanti contenuti nel nuovo decreto aprono una strada che
porterà in breve novità più rilevanti.
Un'ultima
considerazione riguarda un'importante positiva ricaduta che questa legge, attraverso
la logica degli obiettivi di qualità integrata con le azioni di tutela
quantitativa, introduce nelle politiche di risanamento e nei relativi piani finanziari.
L'individuazione di obiettivi definiti e misurabili, contestualmente alla definizione
di precisi traguardi temporali (2008 obiettivo intermedio e 2016 obiettivo finale)
in cui questi obiettivi devono essere raggiunti, costringerà la pianificazione
a una logica per obiettivo. Sarà necessario pianificare l'utilizzazione
delle risorse che si rendono disponibili nella maniera più consona per
il raggiungimento dei risultati attesi; inoltre la presenza di standard di qualità
ben definiti renderà misurabili gli effetti degli interventi, permettendo
così di valutarne il rapporto costo benefici, l'efficacia e l'efficienza.
In questo modo, gli investimenti della Comunità europea o dello Stato potranno
più facilmente essere orientati verso quegli interventi che rispondono
di più a questa logica.
di Riccardo
Rifici, Irene Di Girolamo
| La
struttura della legge |
 |
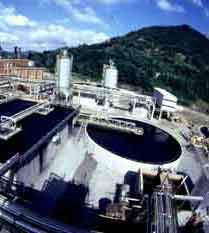 |
| Un depuratore
industriale |  | Il
decreto legislativo n. 152/99 è organizzato in 6 Titoli,
7 Allegati
tecnici, 8 Decreti attuativi.
I titoli
- Principi generali
- Obiettivi di qualità
- Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
- Gestione dei corpi
idrici
- Sanzioni
- Disposizioni finali
Gli allegati
Allegato 1 - Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli
obiettivi di qualità ambientale. Contiene i criteri per l'identificazione
e la classificazione dei corpi idrici significativi.
Allegato 2
- Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale. Riporta
i criteri generali e le metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative
e per la classificazione delle acque superficiali, secondo la normativa vigente:
in particolare quelle delle acque superficiali destinate alla produzione di acque
potabile (dpr 3 luglio 1982 numero 515), delle acque superficiali idonee alla
vita dei pesci salmonicoli e ciprinicoli (dl 25 gennaio
1992 numero 130) e
di quelle destinate alla vita dei molluschi
(dl 27 gennaio 1992 numero 131).
Tali norme vengono abrogate
con l'entrata in vigore della nuova legge.
Allegato 3 - Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi
dell'impatto esercitato dall'attività antropica. Vengono previste, per
le acque superficiali e per quelle sotterranee, due distinte fasi: una finalizzata
all'acquisizione delle conoscenze disponibili e una relativa alla costituzione
di un archivio anagrafico dei corpi idrici. Per quanto riguarda la prima fase
sono riportati gli elementi geografici, geologici, idrogeologici, fisici, chimici,
biologici e socioeconomici da prendere in considerazione per la caratterizzazione
dei bacini. Relativamente alla seconda fase sono indicate le modalità per
la compilazione di una scheda informatizzata che riporti, per ciascun corpo idrico,
tutte le informazioni sugli impatti esercitati dalle attività umane.
Allegato 4 - Contenuti dei piani di tutela dei bacini idrografici. Riporta
i criteri e le modalità per la redazione dei piani di tutela e la gestione
degli interventi e delle misure previste dal piano stesso.
Allegato 5
- Limiti di emissione degli scarichi idrici. Riguardante le norme di emissione
per gli scarichi degli impianti di acque reflue urbane, recapitanti in aree sensibili
e non, e delle acque reflue industriali.
Allegato 6 - Criteri per l'individuazione
delle aree sensibili e meno sensibili. Vengono definiti, in ottemperanza alla
direttiva 91/271/Cee, i criteri per l'individuazione o la reidentificazione da
parte delle regioni delle aree sensibili o meno sensibili.
Allegato 7
- Zone vulnerabili. Riporta i criteri per l'individuazione o la reidentificazione
da parte delle Regioni delle zone vulnerabili, nonché i criteri e la metodologia
per la definizione dei programmi di azione da parte delle stesse Regioni. È
diviso in due parti, la prima riguarda le zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola e la seconda le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.
I
decreti attuativi
- Norme
tecniche per la movimentazione dei fondali marini e lo sversamento in mare. Decreto
del Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori pubblici e per
le Politiche agricole, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
nuovo testo di legge.
- Criteri
e modalità per l'applicazione sul terreno di effluenti zootecnici e acque
di vegetazione. Decreto del Ministro per le Politiche agricole di concerto con
i Ministri dell'Ambiente, dell'Industria, della Sanità e dei Lavori pubblici
da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo di legge.
-
Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue urbane. Decreto del Ministro
dell'Ambiente di concerto con i Ministri per le Politiche agricole, della Sanità,
dell'Industria e dei Lavori pubblici.
- Criteri
relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività
di acquacoltura e piscicoltura. Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto
con i Ministri per le Politiche agricole, dei Lavori pubblici, dell'Industria
e della Sanità.
- Criteri
per la standardizzazione dei dati e per la trasmissione delle informazioni. Decreto
del Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri competenti e la conferenza
Stato-Regioni (in via di predisposizione da parte dell'Anpa).
- Criteri
per la definizione del bilancio idrico di bacino. Decreto del Ministro dei Lavori
pubblici di concerto con i Ministri competenti e la conferenza Stato-Regioni.
- Criteri per la definizione
delle modalità per l'applicazione delle riduzioni del canone previste dall'articolo
18 della legge 36/94. Decreto del Ministro dei Lavori pubblici di concerto con
i Ministri competenti e la conferenza Stato-Regioni.
- Criteri
per la predisposizione dei progetti di gestione dell'attività di "manutenzione"
delle dighe. Decreto del Ministro dei Lavori pubblici di concerto con i Ministri
competenti e la conferenza Stato-Regioni
|  |
| | |
| | | | |
| | | |
