ACQUA
> SPECIALE ACQUA > LA SCIENZA PER
L'ACQUA > IL NUOVO CORSO DELL'IDROGEOLOGIA
La scienza per l'acqua
Il nuovo corso dell'idrogeologia
Negli anni '70 e
'80, la raccolta dei dati idrologici mirava soprattutto a ottenere le informazioni
di base necessarie allo sfruttamento delle risorse d'acqua per soddisfare i bisogni
e alla riduzione delle perdite umane e materiali imputabili alle inondazioni.
I dieci anni successivi sono stati maggiormente imperniati sulla gestione delle
risorse, nell'ottica dello sviluppo durevole.
Se si è passati,
in materia di applicazione dei dati idrologici, dalla valorizzazione all'utilizzazione
durevole delle risorse, lo scopo primario della riduzione (gestione) dei rischi
non è cambiato. Nello sfruttamento delle risorse idriche, si è cercato
di attenuare la minaccia di interruzioni dell'approvvigionamento o i danni di
eventi estremi, siccità e inondazioni, per le persone e i beni. L'obiettivo
era che le risorse fossero disponibili nel luogo e al momento voluto per il rifornimento
delle città, per l'agricoltura, la navigazione o altri usi. I dati idrologici
sono stati sempre considerati utili alla protezione dell'ambiente, ma non sono
sempre stati una priorità. Fra i rischi ai quali dobbiamo fare fronte oggi
figurano la proliferazione delle alghe, la salinizzazione, la distruzione degli
habitat naturali e l'aumento del numero di specie minacciate.
La chiave
della riduzione dei rischi risiede nella conoscenza delle risorse d'acqua nella
loro variabilità naturale. Gli archivi a lungo termine costituiscono la
migliore risorsa di sapere in materia. Tuttavia, mentre ci occupiamo oggi di aspetti
diversi di queste risorse, abbiamo bisogno di altre informazioni e manchiamo di
dati integrati, soprattutto sulla qualità, sul consumo e sulla domanda.
| Per
una gestione durevole dell'ambiente |
 I
dati idrologici negli anni '70 e '80 erano finalizzati allo sfruttamento delle
risorse e alla riduzione delle perdite umane e materiali. I
dati idrologici negli anni '70 e '80 erano finalizzati allo sfruttamento delle
risorse e alla riduzione delle perdite umane e materiali.
Negli ultimi anni
la loro utilizzazione e applicazione sono invece state indirizzate alla gestione
delle risorse stesse, nell'ottica dello sviluppo sostenibile
|
| |
Nuove
applicazioni dei dati idrologici e connessi
Come abbiamo visto sopra,
i principi legati alla gestione delle risorse d'acqua sono profondamente cambiati
negli anni '90. Sono stati precisati e studiati in occasione di numerosi incontri
internazionali, quali la Conferenza internazionale sull'acqua e l'ambiente a Dublino
nel 1992 (Acc/Isgwr, 1992) e la Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente
e lo sviluppo che ha definito il programma Azione 21 (Cnued, 1992). Essi sono:
- la visione dell'acqua come bene economico al quale è attribuito un valore,
in tutte le sue utilizzazioni;
- l'importanza dell'acqua per lo sviluppo durevole;
- la natura multidisciplinare della gestione delle risorse d'acqua;
- il riconoscimento
che l'acqua dolce è una risorsa rara e fragile, indispensabile a tutte
le forme di vita.
Questi sono tutti principi fondamentali per l'ambiente,
ma il secondo e il quarto, insistendo sull'importanza dell'acqua per lo sviluppo
durevole e per il mantenimento della vita, rappresentano una netta evoluzione
della prospettiva. Si è sentita più forte la necessità di
ottenere informazioni che facilitino la gestione delle risorse d'acqua nell'ottica
dello sviluppo durevole. Invece, l'applicazione di regole di redditività,
derivanti dalla visione dell'acqua come bene economico, ha gravemente pesato sui
budget destinati ai gruppi incaricati di raccogliere dati a lungo termine a sostegno
dei processi decisionali. Credo sia tempo di tornare all'essenziale e di valutare
i dati sull'idrologia e le risorse d'acqua che accumuliamo. Dobbiamo ridefinire
le nostre necessità alla luce di numerosi criteri: tipi di dati ottenuti,
attendibilità e classe di qualità secondo le applicazioni (compresa
l'integrazione delle reti di raccolta). Nei termini della Guida delle pratiche
idrologiche (Omm, 1994), dobbiamo rivedere la raccolta, il trattamento e la diffusione
dei dati.
Tipi
di dati raccolti
È fondamentale, per lo sviluppo durevole presente
e futuro, avere informazioni esatte sulla quantità, la variabilità
e la qualità delle risorse d'acqua di ogni nazione. La piovosità
e, di conseguenza, il flusso variabile nella maggior parte delle regioni, alcune
sottoposte a lunghi periodi di siccità, altre a inondazioni devastanti.
La domanda cresce praticamente ovunque, inasprendo la competizione fra gli utilizzi.
La qualità e la quantità tendono a variare, le precipitazioni sono
difficili da prevedere e le fonti di approvvigionamento sono spesso lontane dai
grandi centri di consumo.
Come abbiamo visto, oggi si mette di più
l'accento sulla gestione durevole che sullo sfruttamento delle risorse idriche.
Si deve quindi allargare il ventaglio dei dati raccolti e riconoscere che siamo
passati dalla semplice raccolta alla creazione di sistemi di informazione integrati
(nel riquadro alla pagina successiva si trovano i tipi di dati idrologici necessari,
fra gli altri, per una gestione durevole delle risorse idriche).
La natura
dei dati non è il solo aspetto importante; le informazioni raccolte devono
avere caratteristiche particolari secondo i nuovi bisogni o l'evoluzione dei bisogni
attuali. Queste caratteristiche comprendono:
- la copertura spaziale (punto,
zona, ecc.);
- la copertura temporale (secondo, giorno, mese, ecc.);
-
la raccolta regolare o intermittente;
- la disponibilità (tempo reale
o differito);
- l'accessibilità (data base o copie cartacee);
-
l'affidabilità/l'esattezza;
- le informazioni descrittive (metadati).
Esempi concreti di utilizzazione
nell'ottica dell'ambiente
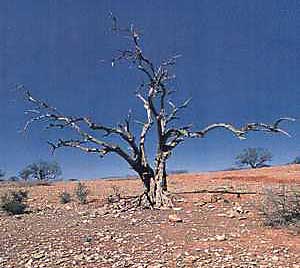 |
| Desertificazione
della savana |
 |
Variabilità
e evoluzione del clima
Il Gruppo intergovernativo di esperti sull'evoluzione
del clima (Giec, 1995) ha pubblicato un rapporto, dal titolo Analisi tecnico-scientifiche
di impatti, adattamenti e mitigazioni del cambiamento climatico, dove si sottolinea
ciò che segue relativamente alle modifiche dell'ambiente (precipitazioni)
legate all'evoluzione del clima: "Globalmente, l'evoluzione del clima potrà
tradursi in un aumento dell'umidità. Secondo gli attuali modelli climatici,
le precipitazioni medie dovrebbero aumentare dal 3 al 15 per cento nel mondo,
per un aumento della temperatura da 1,5 a 4,5° C. Se è probabile che
la piovosità aumenti in alcune regioni e diminuisca in altre, i risultati
non concordano per quanto riguarda il volume o la distribuzione delle precipitazioni".
Più di recente, la seconda Conferenza internazionale sul clima e l'acqua
(Espoo, Finlandia, agosto 1998; Omm/Unesco, in stampa) ha concluso, per quanto
concerne l'incidenza dell'evoluzione del clima sul genio idraulico: "...questo
insieme di lavori soffre di una carenza evidente di armonizzazione scientifica,
ciò che rende per il momento difficile la valutazione obiettiva della sua
utilità globale per i decisori".
È chiaro che occorre interrogarsi
sull'ipotesi attuale di "stazionarietà" delle serie cronologiche.
Si devono dunque assolutamente mantenere siti di misura del flusso a lungo termine
nelle aree poco toccate dalle attività umane. Inoltre, questi siti permetteranno
di condurre progetti mondiali sul clima, quali il Sistema mondiale di osservazione
sul clima (Smoc) e il Sistema mondiale di osservazione dell'ambiente terrestre
(Gtos).
Flusso
negli ambienti naturali
La costruzione di un serbatoio ha ripercussioni
sul regime dei fiumi. Ogni opera attuale o futura deve permettere il flusso d'acqua
negli ambienti naturali. Si deve anche determinare l'apporto necessario agli ecosistemi
fluviali come pure alle zone umide. Se si vogliono assicurare questi flussi e
sfruttare le riserve in maniera efficace, è necessario disporre di informazioni
sui flussi di entrata e sul consumo e la domanda di acqua per altri usi. C'è
sempre più bisogno di sistemi di sorveglianza in tempo reale al fine di
stabilire piani di stoccaggio e di irrigazione. Il flusso negli ambienti naturali
e il riconoscimento del valore economico dell'acqua sollevano ugualmente la questione
dei diritti scambiabili. Il commercio di acqua sembra un modo equo di giungere
ad aggiustamenti strutturali nelle zone irrigue e di passare da un consumo debole
o marginale a usi di più grande valore, quali il flusso nell'ambiente per
le zone umide, i corsi d'acqua, ecc.
Gestione
delle pianure alluvionali e delle zone umide
Le pianure alluvionali
e le zone umide sono indispensabili all'equilibrio ambientale. Purtroppo, le prime
sono ambite per l'agricoltura e come zone di edificazione di città, mentre
le seconde sono sacrificate in gran numero alle costruzioni residenziali e ad
altre destinazioni urbane. C'è bisogno di informazioni idrologiche per
lottare contro le inondazioni e trarre profitto dalle zone umide al fine di garantire
la quantità e la qualità delle risorse, stabilendo diverse condizioni
naturali e ecologiche. È necessario conoscere i livelli di crescita, la
configurazione del flusso, i flussi passati, le caratteristiche idrauliche delle
zone umide e delle pianure alluvionali, ecc. per condurre al meglio questi cambiamenti
di modo sano e durevole.
Gestione dei corsi d'acqua
 |
| Una foresta
primigenia |
 |
Queste misure mirano a proteggere i corsi d'acqua da attività che nuocciono
alla loro struttura e agli habitat naturali. Per esempio, l'estrazione di sabbia
e ghiaia dal letto o dalle sponde di un fiume può avere effetti nefasti
sull'equilibrio ecologico. Nell'ambiente fragile e dinamico che lo costituisce,
i lavori di escavazione rischiano di accelerare l'erosione, di modificare il corso
del fiume o di deteriorare poco a poco gli ecosistemi. Lo sradicamento degli alberi,
dei cespugli, ecc. ha le stesse conseguenze. I dati utilizzati in questo caso
comprendono l'idraulica del fiume, la qualità dell'acqua, la sedimentazione,
l'utilizzazione delle terre, i bisogni della fauna e della flora che vivono in
questo ambiente.
Indicatori
dello stato dell'ambiente
Gli Stati esigono sempre più che i progetti
che beneficiano di finanziamenti pubblici si traducano in un miglioramento considerevole
dell'ambiente naturale. È dunque importante poter seguire lo stato dell'ambiente
e valutare così i programmi di ripristino e le politiche adottate. Molti
indicatori integrano i dati idrologici, fra cui l'altezza della falda freatica,
lo scambio di sostanze nutritive, la presenza di pesticidi, le tendenze della
salinità nei corsi d'acqua, le risorse e la domanda, i regimi di flusso
e il disboscamento dei bacini scolanti.
Conclusioni
e raccomandazioni
Il bisogno fondamentale di dati idrologici e connessi
per diversi usi resta inalterato. Ma molte cose si sono evolute:
- l'importanza
accordata allo sviluppo durevole e all'ambiente;
- l'evoluzione delle
caratteristiche dei dati raccolti, grazie alle capacità di modellizzazione
e ai progressi tecnici;
- la visione globale adottata per la raccolta
di informazioni, tenendo conto delle interazioni fra il ciclo idrologico e la
terra;
- il bisogno di dati quali le caratteristiche (qualità,
rapidità, ecc.) varia in funzione della loro destinazione.
Di conseguenza, i Paesi dovrebbero:
- riconoscere il ruolo determinante
dei dati idrologici e connessi con la gestione delle risorse idriche secondo il
principio dello sviluppo durevole;
- rivedere i loro bisogni in funzione
dei tipi di dati raccolti, della precisione richiesta e della classe di qualità
secondo le applicazioni e gli usi;
- creare e adottare costantemente
le reti integrate che corrispondono ai bisogni attuali e futuri di informazione;
- vigilare affinché la sorveglianza dei dati idrologici e connessi
prosegua nei vecchi siti al fine di misurare l'incidenza della variabilità
e dell'evoluzione del clima;
- contribuire agli studi idrologici mondiali
trasmettendo i dati idrologici e connessi si cui si dispone;
- integrare
nelle attività di valutazione, di uso e di gestione delle risorse d'acqua
i progressi compiuti in materia di raccolta dei dati e di modellizzazione idrologica;
- percepire la natura multidisciplinare di valutazione, di valorizzazione
e di gestione delle risorse d'acqua e tenerne conto nella raccolta dei dati idrologici
e connessi;
- conservare le loro reti in modo da utilizzare al meglio
le risorse allocate per farlo, raccogliendo dati e informazioni utili a diversi
usi, consapevoli che le caratteristiche che dovranno presentare questi ultimi
potranno variare in funzione della loro destinazione.
B.J. Steward
Capo dell'Idrologia all'Ufficio meteorologico
di Melbourne, Australia
Presidente del gruppo di lavoro dei sistemi di
base della Commissione di idrologia dell'Omm
Tratto
da Bulletin (Bollettino dell'Organizzazione meteorologica mondiale), volume 49,
n. 3, luglio 2000, pgg. 248-253
L'Omm
ha sede a Ginevra, cp 2300, CH-211 Genève 2, Suisse
